Giuliano Giacomelli è un regista, aiuto regista e sceneggiatore italiano nato ad Isola del Liri nel 1989. Si è avvicinato al cinema da autodidatta e ha mostrato una particolare predilezione per il cinema di genere. Nel 2019 ha presentato il suo primo lungometraggio, “Profondo”, al Cinefantasy International Fantastic Film Festival di San Paolo del Brasile, dove è stato scelto come pellicola utile a rappresentare l’Italia nella competizione ufficiale. Il film ha ricevuto una buona accoglienza soprattutto nei portali specializzati di cinema indipendente e di genere. Abbiamo avuto il piacere di fare con Giuliano Giacomelli una lunga e interessante chiacchierata sul mondo del Cinema Indipendente.
Come hai sviluppato il tuo interesse per il cinema di genere? C’è stato un film o un regista che ti ha influenzato particolarmente?
Inizio citando George Lucas e palesando sin da subito la mia attitudine al nerdismo: Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana… c’era un bambino che trascorreva la sua infanzia guardando film. Solamente film. Non faceva nient’altro. Ma la cosa divertente è che non si trattava della solita roba che di solito guardano i bambini, film d’animazione o film per famiglie. Quelli mi annoiavano tantissimo, soprattutto i film d’animazione (che paradossalmente ho riscoperto con l’età adulta), perché non riuscivo ad identificarmi con qualcosa che era dichiaratamente finto. Come potevo identificarmi con un disegno?! Per me, all’epoca, era inconcepibile. E quindi mi sono lasciato guidare al cinema da mio fratello, che è più grande di me di sei anni, e quindi quando io avevo sette anni lui già ne aveva tredici e non faceva altro che leggere Dylan Dog o registrare in tv film dell’orrore. Ricordo che andavamo quasi tutti i giorni ad “Hollywood In”, la videoteca sotto casa, e noleggiavamo tutti quei film che poi sono diventati i classici del cinema horror post-moderno. Quindi il mio imprinting cinematografico è avvenuto con film come La casa di Sam Raimi, Nightmare – Dal profondo della notte di Wes Craven, La bambola assassina di Tom Holland (il regista ovviamente, non l’omonimo che adesso fa Spiderman!), La notte della lunga paura di William F. Claxton o Quel motel vicino alla palude e Non aprite quella porta di Tobe Hooper. Soprattutto quest’ultimo mi aveva proprio stregato e tipo all’età di dieci anni ne ero diventato proprio dipendente. Era sporco, feroce, affascinantissimo. Quando hai dieci anni come fai a non impazzire davanti a questo tipo grande e grosso – Letaherface – che corre per le campagne assolate del Texas con una motosega in mano?! Per me era un wow continuo! Quindi ecco, per rispondere alla tua domanda, per me non c’è mai stato un interesse cinematografico prima della scoperta del cinema di genere. Ho scoperto prima il cinema di genere, poi tutto il resto del cinema. Ammettendo che possa esistere un cinema che, di fatto, possa non essere di genere. Quindi se oggi sono un patito di questo tipo di cinema è prevalentemente colpa di mio fratello, che mi ha di fatto svezzato alla settima arte, e dei miei genitori che mi hanno lasciato sempre totale libertà di vedere tutti i film che volevo. Senza preoccuparsi minimamente se quello che stavo vedendo era teoricamente adatto ad una bambino di quell’età.
Come hai iniziato la tua carriera nel mondo del cinema? Quali sono state le prime esperienze professionali che ti hanno portato a diventare un regista?
È iniziato tutto come un gioco, ovviamente. Quando smetti di creare storie con i giocattoli inizi a sentire l’esigenza di continuare a creare storie ma con le persone vere. E ricordo molto bene che i primi esperimenti cinematografici – voglio abusare di questo termine – gli ho iniziati a fare con la videocamera digitale 8mm che i miei mi regalarono quando feci la prima comunione.Sempre con mio fratello ci divertivamo a fare piccoli filmini amatoriali con il montaggio in camera dove inventavamo storie di fantasmi, assassini e cose così. E quindi inconsapevolmente ho iniziato a sperimentare i veri trucchi artigianali del cinema. Poi questa roba mi è rimasta, perché mi divertiva troppo e mi piaceva l’idea di far vedere agli altri qualcosa di incredibile che avevo fatto io insieme a mio fratello. Quindi ho passato tutta l’infanzia e poi l’adolescenza a fare filmini amatoriali e a rincorrere l’idea, anzi il sogno/bisogno, di riuscire a fare prima o poi qualcosa di più strutturato.Alla fine ho sempre voluto fare film, sin da piccolissimo sapevo che avrei continuato su questa strada. Così, terminato il liceo, mi sono iscritto al DAMS di RomaTre (un’università che mi ha convinto ancora di più che l’unica vera scuola di cinema è il Cinema stesso!) e qui ho avuto la fortuna di conoscere, per la prima volta, persone che condividevano i miei stessi obiettivi. Ovviamente l’incontro più fortunato è stato quello con Lorenzo Giovenga, grande amico e collega, con il quale ho iniziato a fare i primi esperimenti un po’ più strutturati (come il lungometraggio La Progenie del Diavolo) e con il quale lavoro ancora oggi.Anche se, questo lo devo ammettere, credo che l’esperienza più formativa di tutte l’ho avuta nel 2011 quando sono stato chiamato dal Lorenzo Bianchini (regista che per me è un maestro assoluto) per fargli da aiuto regia sul set dell’horror Across the River – Oltre il guado. Ecco, quel set è stato davvero il punto di non ritorno all’interno del mio percorso professionale.
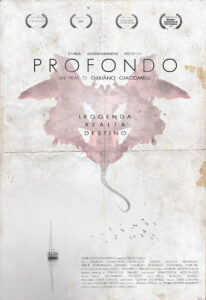
Parliamo del tuo primo lungometraggio, “Profondo”. Come hai avuto l’idea per questa storia e qual è stata la tua ispirazione?
Se c’è una cosa che mi è sempre piaciuta da morire sono i mostri. E se c’è una cosa che mi piace ancor più dei mostri, sono i mostri marini. Mi rendo conto che sotto questo aspetto, oggi che ho superato i trent’anni, sono rimasto
assolutamente identico a come ero quando avevo cinque anni. Più i mostri sono grandi, pericolosi e minacciosi, e più sono felice. E il concetto di “mostro” mi piace in tutte le sue declinazioni, sia nel caso dei mostri fantastici (penso a King Kong e Godzilla) che in quello dei mostri reali. Ho sempre considerato il beast-movie come uno dei sottofiloni più fomentati in assoluto. Quando ero piccolo, oltre ad impazzire dietro ai texani con la motosega e che mangiavano carne umana, impazzivo anche dietro ai film con i mostri giganti o gli animali assassini. Non dimenticherò mai l’emozione provata a otto anni quando mio padre mi portò al cinema a vedere Anaconda di Luis Llosa (era il novembre del 1997). Visto a otto anni, sul grande schermo poi, era qualcosa di davvero incredibile: un esplosione assurda di avventura, azione, mistero e animali ferocissimi che facevano cose incredibili. Quello, per il me dell’epoca, era davvero il cinema nella sua forma più alta. Ma se ci avventuriamo in certi discorsi potrei perdermi in sproloqui che meriterebbero un’intervista a parte perché dovrei finire inevitabilmente per parlare de Lo Squalo di Steven Spielberg che per me – ad oggi – resta di fatto il più grande film che sia mai stato fatto. Cioè, proprio la perfezione assoluta dove ogni cosa è al posto giusto. L’avventura, l’horror, l’azione, la commedia, i mostri appunto (sfido chiunque a dire che quello squalo lì non faceva paura). Una combinazione incredibile di ingredienti talmente perfetta che non è mai più stata replicata da nessuno. E onestamente credo sia impossibile bissare quanto fatto da Spielberg nel 1975. Ed è proprio l’unione di tutte queste cose qui, compreso anche l’amore che nutro nei confronti del King Kong del 1933 (che continuo a considerare il film più romantico di tutta la Storia del Cinema), che mi ha condotto a pensare a Profondo. Anche perché, quando fai un film fuori dai meccanismi del Sistema e lo realizzi tramite auto-produzione, non è detto che dopo ne farai un altro. Quello potrebbe essere il tuo primo ed unico film. E dunque, pensando proprio a questo, volevo fare un film con dentro davvero tutto quello che amo di più del cinema: quindi l’avventura, il mistero, la leggenda marina, il dramma introspettivo e la fascinazione per i mostri. Volevo davvero realizzare un film capace sia di rendere onore al cinema che mi faceva emozionare quando ero piccolo ma anche un film che poteva parlare di me, oltre che per me. Profondo non è solo la mia opera prima, in un certo senso sono proprio io. Si può capire e conoscere moltissimo di me vedendo il film.
Quali sono state le sfide più grandi che hai incontrato durante la produzione di “Profondo”? Come le hai superate?
Tutte! Come dico sempre, se c’è qualcosa che poteva andare storto…è andata storta! Abbiamo avuto solo difficoltà durante la lavorazione del film, ma c’era anche da aspettarselo perché Profondo non era assolutamente il film giusto da girare nelle condizioni in cui ero: poca esperienza, una troupe ridotta all’osso e – soprattutto – niente produzione e nessun budget. Molti registi, quando esordiscono con un budget contenuto (parlo anche di cinema mainstream, non solo di indipendente), si mettono alla prova con film misurati: poche e semplici location, tanta atmosfera a discapito dell’azione narrativa. Ed è giusto così. Io invece, complice il discorso di prima, volevo fare tutto e subito. Quindi vai con l’idea di girare tutto un film in mare aperto e su un piccolo peschereccio di pochi metri. Alla fine girare il film è stata un’avventura tanto quanto quella che compie il protagonista alla ricerca del Diavolo Rosso. La più grande difficoltà è stata quella di avere una troupe composta davvero da sei persone. E non potevano essere di più, sia per una questione economica e sia perché il peschereccio non era pensato per ospitare più persone. Quindi, essendo pochissimi, tutti dovevano fare tutto e i ruoli non erano quasi mai davvero definiti. Davvero la troupe di Profondo è stata composta da eroi del cinema, persone che non smetterò mai di ringraziare per i sacrifici che hanno fatto durante le riprese. A questo si aggiungono anche tutte le difficoltà produttive che ho dovuto affrontare mentre giravo. Profondo non ha mai avuto una vera fase di preparazione e quindi, altra follia, il film si preparava a mano a mano che giravamo. Ma io non avevo nessuna figura di produzione né aiuto regia ad assistermi. Questo significa che non c’era nessuno che organizzava il set mentre io giravo in mare aperto. Dovevo fare tutto da me e quindi, mentre sul peschereccio si allestivano le scene, io mi mettevo a poppa col telefono a chiamare, ad esempio, per le location del giorno successivo. A complicare il tutto, ovviamente, mettici pure il mal di mare. Nessuno di noi era abituato a lavorare in mare aperto e quindi abbiamo scoperto di soffrire quasi tutti il mal di mare. Nel migliore dei casi, tra un ciak e l’altro, si andava tutti a vomitare e poi si ricominciava. Ma in alcuni momenti abbiamo dovuto proprio interrompere la giornata di ripresa perché gli attori stavano male e non riuscivano proprio più a recitare.
Devo continuare con le difficoltà?
Allora ci metto che le riprese sono combaciate con il terremoto di Amatrice, che ha avuto come conseguenza un mare incazzato per giorni e giorni. E quindi l’impossibilità ad uscire in mare aperto per quasi una settimana e mezza. Va da sé che molte scene ho dovuto riadattarle in corsa, altre addirittura eliminarle completamente dalla sceneggiatura perché non c’era più tempo per girare. Poi, chiuso il set, duemila problemi con la post-produzione che mi hanno portato a dover lavorare tre volte sui vfx e due volte sull’intero sound design del film.
Davvero potrei andare avanti per ore e ore parlando delle complicazioni che si sono presentate durante le riprese e subito dopo.
La verità è che certe difficoltà le superi solamente grazie al gruppo unito, c’è poco da dire. Io devo ringraziare tantissimo Marco Marchese, che è stato davvero il miglior compagno di viaggio che si possa immaginare, perché oltre a fare il protagonista del film mi ha dato una mano su tutto e in ogni momento, evitando davvero di farmi sentire solo. Ma oltre a lui devo tanto anche alla mia d.o.p. Marina Kissopoulos che, oltre a fare un lavoro pazzesco, ha cercato di esaudire ogni mia richiesta folle, così come devo ringraziare tutta la troupe che mi ha sempre sopportato anche quando chiedevo loro tantissimo (ogni giorno giravamo dodici o tredici ore, finché ci reggevano le gambe, altro che straordinari!). Quindi è solo grazie all’energia che ti viene da un gruppo davvero unito e che crede fermamente in quello che stai facendo che si riescono a superare le enormi difficoltà. E poi certo, c’era da parte mia anche una determinazione enorme a chiudere il film. Costi quel che costi. Perché dovevo dimostrare che tutto quello che avevo messo in piedi aveva un senso, che era possibile girare un film in quelle condizioni. Quasi un bisogno di rivincita personale dopo anni e anni trascorsi a scrivere film che non ho mai girato. Ma qui si entra nell’irrazionale ed è difficile spiegarlo in poche parole.
Invece quale è stata la tua ispirazione per il tuo cortometraggio “Intolerance”?
La genesi di Intolerance è completamente diversa invece. Perché se Profondo è venuto fuori da un’esigenza viscerale di dimostrare a sé stessi, ma anche agli altri, ciò che si vale…Intolerance è stato il frutto di un lavoro molto più ponderato e costruito. Maturato negli anni, oserei dire.
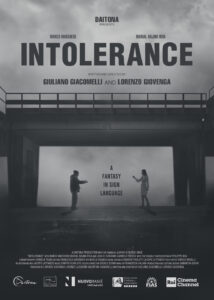
L’idea di Intolerance risale al 2009, al primo anno di università. Avevo rivisto da poco un film a episodi che avevo amato da bambino, I delitti del gatto nero di John Harrison (1990). In quel film c’è un episodio bellissimo, il terzo, che è un insieme di fantasy e horror. Tutto avvolto da una squisita ambientazione metropolitana e da quest’alone di magia che ha dell’incredibile. Lì c’era questo tipo squattrinato che per caso, una notte, diventa testimone di un omicidio atroce per mano di un mostro rivoltante simile ad un gargoyle. Il mostro lo risparmia e gli dice che non gli avrebbe fatto nulla se solo fosse stato in grado di mantenere il segreto su ciò che ha visto. Quindi il tipo, assolutamente terrorizzato, promette al mostro che non avrebbe mai detto niente a nessuno. E infatti è quello che fa. Rispetta la promessa per tutta la vita, senza difficoltà, finché non pensa bene di mettere su famiglia e allora, beh, a quel punto mantenere certi segreti diventa davvero difficile.
Quel singolo episodio di quel film di Harrison aveva la capacità di creare davvero un mondo. Una situazione assolutamente incredibile calata all’interno di un contesto che invece è credibilissimo. Il magico che incontra naturalmente il reale. Insomma l’atmosfera di quel film mi aveva lavorato dentro così tanto che, in breve, mi ritrovo a parlarne con Lorenzo Giovenga, che avevo conosciuto da poco al DAMS. Ci mettiamo subito a buttare giù idee e suggestioni e così nasce il soggetto di Intolerance, una beffarda storia urbana e dai tratti neorealisti che, nel finale, assume dei connotati squisitamente fantastici e mostruosi. L’idea è rimasta nel cassetto per dieci anni fino a quando, nel 2019, spinti dalla voglia di partecipare al bando di produzione indetto dal NuovoImaie, decidiamo di rispolverare quell’idea avuta dieci anni prima e che ancora risiedeva in qualche meandro della nostra memoria. Lo iscriviamo al bando anche un po’ per gioco, lo ammetto, perché mai e poi mai potevamo immaginare che una storia del genere potesse essere finanziata dall’Imaie. Cioè, era folle già solo a leggerla. E invece a sorpresa abbiamo vinto e quindi, da lì a poco, ci siamo ritrovati davvero a capire come cavolo si poteva realizzare una roba del genere. Comunque l’idea mia e di Giovenga, perfettamente allineati sotto questo aspetto, era anche quella di provare a realizzare un film capace di parlare di disabilità in un modo assolutamente diverso. Quando abbiamo girato Intolerance ancora non era esplosa questa tendenza a realizzare film sulla sordità (a memoria ricordo solo The Tribe, che è un film ucraino del 2014, e La famiglia Belier, sempre del 2014, ovvero la commedia francese da cui, solo nel 2021, hanno poi tratto il remake che adesso tutti conosciamo). Quindi, in un certo senso, siamo stati i primi a raccontare il mondo dei sordi in un modo assolutamente non convenzionale. Con Lorenzo Giovenga ci siamo sempre domandi per quale motivo, il cinema a carattere sociale o che esplora le disabilità, deve sempre e per forza essere un cinema triste, sempre così drammatico e depressivo a tutti i costi. Perché non provare a parlare di sordità utilizzando la chiave del cinema fantastico? Sin dai tempi antichi il cinema di genere ha offerto chiavi di lettura importanti per parlare di politica, di fede, di ambientalismo. Tutto. E quindi si, eravamo fermamente convinti che si poteva applicare una chiave di lettura simile anche nei confronti della sordità.
Come hai lavorato con gli attori per creare la tensione emotiva necessaria nel film “Profondo” e nel cortometraggio “Intolerance”?
Il lavoro con gli attori è una cosa che mi interessa sempre tantissimo. Perché è una cosa molto difficile e quindi stimolante. Poi la cosa bella è che non c’è un metodo da seguire che possa essere quello giusto. Non c’è una vera regola che ti dice come è corretto lavorare con un attore e come invece è sbagliato. Si tratta di sensibilità, nient’altro, ed è una cosa che si modifica ogni volta, una dinamica che cambia in base all’attore che hai davanti. Ed è bellissimo, perché si entra nel mondo delle sintonie empatiche ed artistiche. Ho sempre pensato che il momento più bello del lavoro con l’attore sia quello che viene prima di raggiungere il set. La preparazione dunque. Quando mesi e mesi prima inizi a parlare del personaggio con l’attore, quando cominci ad entrare nella storia insieme a lui. Amo tantissimo il dialogo con gli attori, credo sia fondamentale, e non mi piace assolutamente imporre solo la mia visione sul personaggio. Perché è una cosa stupida ed equivale ad aumentare il rischio che quel personaggio possa risultare finto sulla scena. A prescindere da quanto sia più o meno bravo l’attore. A me piace tantissimo quando l’attore, in base alla propria sensibilità e al proprio background, decide di intervenire sul carattere del personaggio. Portandoci dentro il proprio bagaglio culturale e facendolo aderire al personaggio interpretato così come alla storia narrata. Ed è così, infatti, che ho lavorato con Marco Marchese in Profondo, ma anche con Nicola Trambusti che nel film interpreta Ion. Abbiamo lavorato per mesi interi sul personaggio. Ho dato a Marco e a Nicola delle reference, naturalmente, per far arrivare ad entrambi il mood che volevo abbracciare. Ma poi il personaggio finale lo abbiamo raggiunto sempre insieme, mettendo dentro anche molto dei loro caratteri. Con Intolerance è stato tutto un po’ diverso perché c’era una grande difficoltà che primeggiava su tutte le altre: ovvero recitare in LIS, nella lingua dei segni. Sia Marco Marchese che Marial Bajma Riva hanno dovuto fare un corso avanzato e privato di LIS insieme ad insegnanti madrelingua. E in questo è stato fondamentale l’aiuto che ci è stato dato dalla FIAS (Federazione Italiana Associazione Sordi) e nella fattispecie da Laura Santarelli.

Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai giù in mente un nuovo film o una nuova serie?
Ho iniziato a pensare al film successivo quando ancora non avevo finito di montare Profondo. E penso che questo sia inevitabile, no?! Come si fa a tenere a bada la creatività?! E questo è pure il grande problema del cinema italiano che, a meno che tu non sia ricco di famiglia e quindi nella possibilità di auto-produrti tutte le volte che vuoi, finisce sempre che passano tantissimi anni prima che tu possa fare un secondo film. Ma ne passano proprio troppi. E questo è un discorso che vale sia per i registi indipendenti che per quelli che provano a fare le cose di Sistema. Perché poi il Sistema, diciamocelo chiaramente, quando ci si mette sa essere ancora più lento e tedioso della macchina indipendente. Mesi e anni buttati, spesi nella speranza di vincere lo sviluppo del Ministero o chissà qualche bando regionale. E se poi non vinci che succede? Niente, aspetti un anno e ci riprovi nella speranza che qualche cosa vada bene. È davvero sfiancante questo sistema, perché conduce inevitabilmente verso due cose: le storie invecchiano e ci si disamora di ciò che si sta cercando di raccontare.
Comunque attualmente si, ho più di qualche progetto in piedi e alcuni di questi cercano persino una produzione (lo dico perché non si sa mai, magari mi legge la persona giusta).
Sempre film più o meno di genere, in cui si mischiano i linguaggi e forme narrative, e appunto si tratta assolutamente di film. Non credo molto nelle serie televisive, lo dico apertamente. Per non farmi mancare nulla, in passato ho provato anche a lavorare su una serie dove c’era stato un primo interesse da parte di Rai Play. È stata una delle più brutte e frustranti esperienze della mia vita, una vera e propria mercificazione delle idee dove il contenuto non conta assolutamente niente. C’è solo la rincorsa stupida e scriteriata a mettere in piedi prodotti sterili, assolutamente senz’anima, dove si guarda solamente alla struttura e ci si dimentica che la cosa più importante dovrebbero essere le emozioni da veicolare.
E posso anche capire la logica dietro tutto ciò, perché alla fine la serie è una roba che dovrebbe essere replicabile all’infinito (almeno nell’accezione più volgare), e quindi, proprio sulla base di questo, mi rendo conto di non essere troppo interessato a questo tipo di grammatica audiovisiva.
Che poi occhio, anche quello della produzione seriale è diventato in questi ultimissimi anni proprio un sistema tossico e spaventoso. Parlo dell’Italia. Tutti a farti credere che c’è una richiesta di serie paurosa, tutti a convincerti che la serie è il linguaggio del futuro. Ma questo non è assolutamente vero. È una falsità. Perché tanto la serie, nella stragrande maggioranza dei casi, non sarà mai degli autori/registi bensì dei broadcast. E in Italia, al momento, di broadcast veri che smerciano serie ne abbiamo tre o quattro. E questi broadcast, alla fine, producono sempre gli stessi (lo dicono i fatti eh, non è una semplice polemica), che poi sono quelli che stanno già dentro al Sistema e che già avevano vita facile anche prima dell’avvento di queste piattaforme che hanno fintamente donato nuovo ossigeno al settore. Anzi, dal mio punto di vista lo hanno solo soffocato.
Come è stata la tua esperienza con la distribuzione di “Profondo” e la sua ustita su Amazon prime Video Italia?
Bella domanda. Qui purtroppo mi devo legare a quanto detto prima e devo ammettere che non è stata una bella esperienza. Io poi non sono un fruitore delle piattaforme, lo dico apertamente, e a casa non ho né Amazon, né Netflix, niente. Sono ancora un cinefilo vecchia maniera che, quando non può andare al cinema, trova rifugio nel supporto fisico. Quindi, partendo da questo, va da sé che l’uscita di Profondo sulle piattaforme è stata – per me – quasi invisibile. Onestamente non mi sono nemmeno accorto.
Io mi vedo costretto a ringraziare Minerva Pictures perché ha creduto nel film e ha deciso di acquisirlo per distribuirlo in pieno covid sia su Amazon Prime, ma anche su Chili, su Google Play e non so dove altro.
Per me è stata una sofferenza gigantesca pensare di rilasciarlo su piattaforma dovendo rinunciare alla sala. Si, perché poi se vedete il film è palese che tutte le immagini sono state pensate e concepite per vivere sul grande schermo. Profondo è un film paesaggistico, un film che vive di scenari naturali, ma anche di primissimi piani che si contrappongono a campi lunghissimi. Profondo, alla fin fine, è un western in mare aperto (girato, tra l’altro, in 2.39:1) e quindi vi lascio immaginare quanto possa respirare sullo schermo di un cinema e quanto, al contrario, possa perdere potenza se visto in tv, o al pc se non addirittura sullo smartphone.
Mi viene l’ansia solo a pensarci.
Io lo dico sempre, il cinema va visto al cinema. Perché il cinema è un’esperienza totale, immersiva e collettiva. Se non lo vivi così non è cinema. Stai solo guardando un film.
E comunque il problema delle piattaforme, e questo lo dico per esperienza diretta, è che sono troppo attente a fare numero piuttosto che a far arrivare quel film nelle case della gente. E ancora una volta rientriamo nel tossico meccanismo della mercificazione del prodotto artistico. Quando Minerva mi ha portato su Prime mi sono reso conto che il mio film non era nulla al di fuori di un numero, una cosa non dissimile dalla valanga di prodotti che quotidianamente finiscono su youtube. Il tuo film viene caricato su una piattaforma. Stop. Né la distribuzione e né il brodcast fanno nulla per promuovere il tuo lavoro. Non c’è proprio l’interesse. E questo cosa significa? Che il film, di fatto, non esiste pur esistendo. Perché se non sei tu a dirlo direttamente che il film si può vedere su Amazn Prime, la gente nemmeno lo sa. E quindi, alla fine, il film arriva solo a quella cerchia di persone che già ti gravano attorno. E questo è il più grande problema delle piattaforme, che alla fine sono interessate a promuovere solo una manciata di titoli. Quei film che, magari, hanno anche prodotto o che comunque rappresentano una garanzia. Tutto il resto serve solo a fare volume.
Film “Profondo” visibile su Amazon Prime Italia
Un saluto ai nostri lettori?
Mi scuso con i lettori di Oltre le colonne se sono stato logorroico, ridondante e polemico. Questo è il problema di noi indipendenti, che spesso fatichiamo a trovare una “platea” vogliosa di ascoltarci. Quindi tante scuse ma, soprattutto, tanti saluti a Oltre le colonne e il suo pubblico. Lunga vita al cinema libero e, ovviamente, lunga vita ai Mostri!








